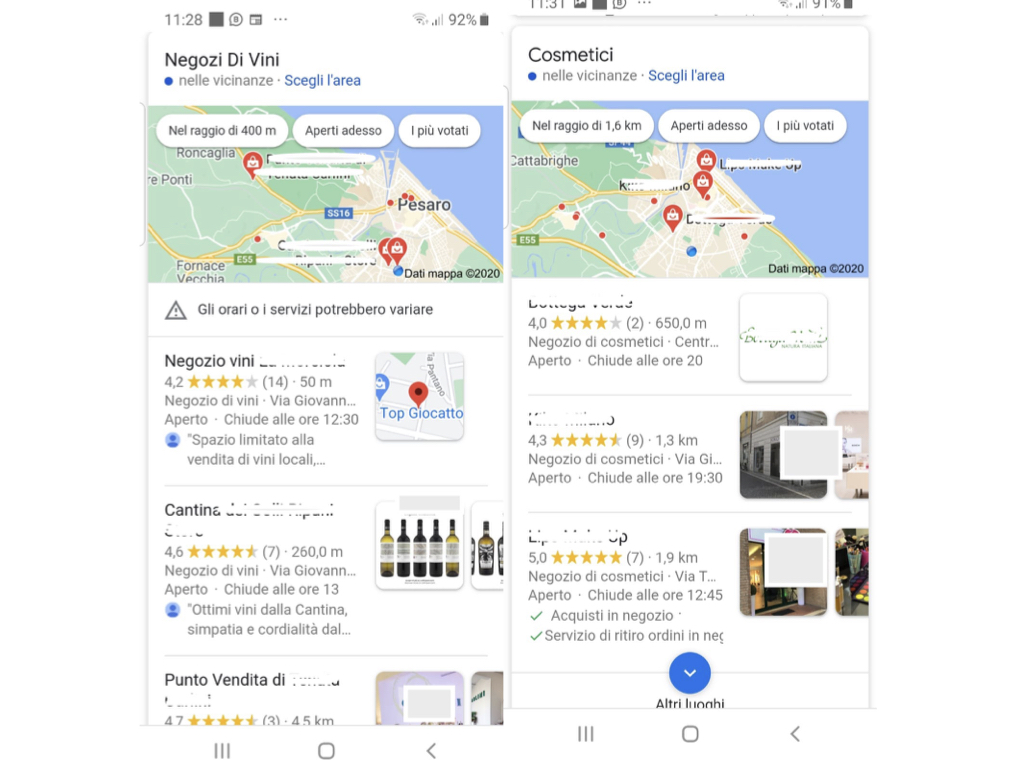da Sergio Bernardini | Nov 5, 2020 | COMUNICAZIONE E BRAND
Dare forma al racconto dei luoghi è l’essenza del legame tra turismo e storytelling. Attraverso il racconto, un luogo acquisisce un’anima che nessuna lista delle caratteristiche potrebbe dare.
- Che cosa è lo storytelling
- Quale è il suo ruolo nel turismo
- Individuare il capitale narrativo
- I miti alla base del racconto e i temi esistenziali
- Personaggi e archetipi narrativi
- Stili di comunicazione
- Gli strumenti per fare storytelling
1. Che cosa è lo storytelling
La traduzione letterale di Storytelling significa “raccontare storie”, ma suggerirei di sorvolare sulla quasi “banalità” del termine per ricordare che esiste una ampia letteratura sulla narratologia che lo rende meno semplice e banale di quel che sembra.
In estrema sintesi occorre fare una distinzione (il termine anglofono può ingannare) tra storia e racconto. Mentre la prima è una successione cronologica di fatti che rappresentano il contenuto, il racconto è la costruzione della narrazione, mediata dall’adozione di determinati canali, “narratori” e stili di comunicazione.
In sostanza lo storytelling è una strategia di comunicazione che veicola attraverso il racconto un’ identità e una storia, fa leva sull’emotività del pubblico-spettatore mirando ad instaurare con esso una relazione empatica.
2. Quale è il suo ruolo nel turismo
Lo storytelling è uno strumento molto potente ed efficace nel settore turistico, perché conferisce un’anima ai luoghi di cui si parla, ne disegna un’alone mitico, entra nella mente dei potenziali visitatori creando le motivazioni per il viaggio.
La narrazione di una destinazione svolge il ruolo di stimolare l’immaginario, aumentare e prolungare il piacere del viaggio, prima, durante e dopo.
Ne consegue che il marketing esperienziale trova nelle strategie di storytelling il suo strumento privilegiato di espressione.
Inoltre lo storytelling, per sua natura legato a dinamiche cronologiche, si unisce facilmente al concetto del “customer journey” o percorso del consumatore, nel processo delle fasi di consapevolezza, valutazione, decisione d’acquisto e post-vendita.
3. Individuare il capitale narrativo
Valorizzare una destinazione richiede di individuare la cosiddetta “Unique selling proposition” ovvero i suoi elementi distintivi.
Non ci si basi sulla consueta lista di caratteristiche, su prezzi o offerte, sempre efficaci si ma totalmente prive di appeal e di capacita empatiche.
Il capitale narrativo di un luogo è l’insieme delle narrazioni che lo identificano e lo rendono unico, la sua storia, i suoi miti e le sue leggende, così come la possibilità di disporre di narratori autorevoli e di saper entrare in relazione con il proprio pubblico di riferimento mediante canali mediali appropriati.

Elementi base per lo storytelling
4. I miti alla base del racconto e i temi esistenziali
Nella costruzione della forma narrativa esistono alcune strutture profonde che catturano la fantasia del pubblico, come miti, temi esistenziali e paure (rif. A. Fontana – Storytelling d”impresa – 2016).
Ricordate il flusso di visitatori che si registrò all’isola del Giglio per vedere il relitto della Concordia? Generalizzando, qualsiasi narrazione tenderà ad essere categorizzabile nelle seguenti tipologie mitiche:
- Mito della salvezza: tutte le storie in cui occorre salvarsi da qualche dramma o persecuzione, dove si cerca rifugio e protezione; storie e misteri delle catacombe di Roma sono un’esempio di questa mitografia;
- Mito della cura: le storie in cui prendersi cura degli altri è prioritario, dove dedizione, sollecitudine e premura dominano la scena; è una forma narrativa tipicamente usata nelle località di cure termali;
- Mito dell’evasione: le storie dove bisogna “fuggire” da qualcosa, implicano trasgressione, disobbedienza, rottura della norma; i luoghi del turismo sessuale rappresentano il mito dell’evasione e della trasgressione per antonomasia;
- Mito della forza: storie dove potere e supremazia rispetto al resto del mondo sono fondativi e manifestano il dominio e il controllo; anche le celebri onde più alte del mondo a Nazarè in Portogallo rappresentano un mito della forza della natura da sfidare.
La costruzione delle mitografie suddette, avrà bisogno di servirsi di alcuni dei seguenti temi esistenziali per creare “pathos”:
- Amore: tutte le forme tematiche del coinvolgimento e della passionalità nelle relazioni;
- Gioco: tutte le forme argomentative del “ludus”, che vanno dal relax alla trasgressione;
- Lavoro: tutte le forme retoriche di impegno, determinazione, dovere, sacrificio, sfida;
- Dolore: tutte le forme tematiche incentrate sulla sofferenza e la difficoltà ad avere, fare, divenire;
- Morte: tutte le forme tematiche di fine, di termine, di perdita di qualcosa, di fine di un progetto.
5. Archetipi narrativi
Le grandi narrazioni si sono sempre articolate tra vari personaggi che interpretano ruoli diversi e compiono gesta di diverso tipo.
Un luogo non può certo assumere questa caratterizzazione, tuttavia “vive” delle storie di persone e delle gesta che lì si sono realizzate, si realizzano o si realizzeranno.
In tal senso esistono alcuni archetipi narrativi dal quale attingere per dare forma al materiale narrativo esistente.

Archetipi narrativi per lo storytelling
6. Stili di comunicazione
L’adozione di un particolare stile comunicativo implica la scelta di parole, sostantivi, aggettivi, predicati verbali, coerenti allo stile prescelto.
L’argomento è assai complesso, tuttavia per dare un breve cenno di indirizzo, per il settore turistico i più comuni sono riportati nella figura sottostante

Stili comunicativi nel turismo
La scelta di uno qualunque di questi stili comunicativi deve essere armonizzata sia con le caratteristiche che si vogliono porre in evidenza, sia con il posizionamento che si è deciso di dare alla destinazione.
7. Gli strumenti per fare storytelling
La costruzione dello storytelling deve poter far ricorso al più ampio mix possibile di canali mediali.
Negli ultimi anni, hanno assunto un ruolo fondamentale i media digitali specialmente per il settore turismo, visto che oltre il 70% delle ricerche di informazioni su una destinazione si svolgono su questi canali e che raggiungono in tempo reale qualsiasi parte del globo.
Non vanno tuttavia sottovalutati i canali tradizionali costituiti da stampati (cataloghi, brochure, depliants, riviste), o altri media di massa come televisione, giornali e radio (laddove le risorse lo consentano), perché anche se sembrano aver perso buona parte del loro appeal, sono tuttora utilissimo complemento dei media digitali per la costruzione della reputazione.
Nella figura un elenco di riferimento ancorchè non esaustivo.

Canali mediali storytelling turismo
Non va infine dimenticata l’utilità di portare avanti attività di P. R. che si sostanziano in organizzazione di meeting, eventi, convention ma anche, visto che si stanno dimostrando estremamente redditizi in termini di popolarità, fare da location per film e fiction televisive.
NOTA: Ampi contributi dei paragrafi 4, 5 e 6 sono stati tratti da Andrea Fontana (Storytelling d”impresa – 2016) – e riadattati da me allo specifico settore turistico.

da Sergio Bernardini | Ott 21, 2020 | COMUNICAZIONE E BRAND
Un breve sunto sul significato e sulla relazione tra turismo e marketing delle esperienze. Riusciranno gli operatori turistici, specialmente nell’ambito della ricettività, ad emanciparsi dalla logica del “vendere una stanza” o saranno presto completamente in ostaggio delle OTA?
Il marketing delle esperienze sta conquistando un ruolo chiave nel settore del turismo perché in pochi altri settori l’esperienza vissuta ha un peso così importante come nei viaggi e nelle vacanze.
Infatti è proprio nella vacanza che il consumatore vive un’esperienza dell’ambiente che lo circonda molto più ampia e pervasiva in confronto a quella che può scaturire dall’uso di prodotti in senso generale.
In sintesi, in un viaggio l’esperienza si matura in tre fasi:
- la fase del sogno che precede il viaggio e che consiste nella ricerca di informazioni, nel pianificare il viaggio, nell’immaginare l’esperienza, nelle aspettative di assaporare le sensazioni che si vivranno durante la vacanza, e include anche il primo vero approccio concreto all’esperienza che si sostanzia nelle modalità di prenotazione, nelle forme di pagamento e nei servizi prenotati.
- la fase esperienziale vera e propria della vacanza in cui si vivono le sensazioni e le emozioni, ma anche le eventuali delusioni o le insoddisfazioni, e tutte queste esperienze saranno costantemente messe a confronto con le aspettative nate nella fase del sogno; perciò è fondamentale non deludere le aspettative nate durante la fase del sogno perché ogni delusione influenzerebbe la cognizione e il ricordo finale dell’esperienza fatta.
- la fase del ricordo, ovvero tutto ciò che il turista si porta dietro al termine del viaggio, che spesso si concretizza con fotografie e souvenir, totem che faranno rivivere l’esperienza trascorsa e ne manterranno viva la narrazione ai loro conoscenti. Questo aspetto è fondamentale nell’alimentare il racconto della località ed al tempo stesso costruire la reputazione di una destinazione. Attraverso il ricordo si alimenta il “passaparola”, fattore che sembra in grado di influenzare la scelta di una destinazione per oltre il 35% dei casi.
Da quanto esposto emerge la fondamentale importanza che per promuovere una destinazione turistica è essenziale stimolare l’immaginazione di un tipo di esperienza che vivrà il cliente piuttosto che elencare una “fredda” lista di caratteristiche.
Infatti questa lista includerà sicuramente molti elementi comuni a tante altre strutture concorrenti, ed il criterio discriminatorio finirà così per concentrarsi solo sul fattore prezzo.
Secondo J. Pine e J. Gilmore (The experience economy-1999) esistono 4 tipi di esperienza a cui fare riferimento:
1. Esperienza di intrattenimento: quando gli individui fruiscono passivamente di ciò che li circonda attraverso i sensi (concerto, teatro);
2. Esperienza educativa: quando l’individuo interagisce con un’evento partecipando attivamente con il corpo o con la mente (interazione, formazione);
3. Esperienza estetica: quando l’individuo è presente fisicamente in un evento di cui percepisce le proprietà con un ruolo passivo (visitare un museo, osservare un tramonto o un paesaggio);
4. Esperienza di evasione: quando l’individuo partecipa attivamente all’esperienza e pone in atto delle azioni (trekking, rafting).
Da questo si comprende come disegnare un’esperienza intorno ad una struttura ricettiva sia piuttosto complicato e spesso riduttivo, mentre ha senso progettarla riferendosi ad una destinazione.

Come mettere in forma l’esperienza turistica
In estrema sintesi, dando per acquisito il passaggio fondamentale che deve determinare “A CHI – COSA – COME – DOVE”, disegnare un’esperienza richiede lo sviluppo di questi elementi:
- Tematizzare l’esperienza turistica, ovvero scegliere un argomento o motivo di fondo che caratterizzerà il soggiorno e la destinazione;
- Pianificare quali saranno gli stimoli che produrranno le impressioni positive e che siano coerenti al tema di fondo;
- Prevedere ed eliminare gli indizi negativi, ovvero tutte quelle cose che possano distogliere l’attenzione dal tema di fondo e “rovinare” così l’esperienza che si costruirà;
- Integrare l’esperienza con “oggetti ricordo”, strumenti che hanno la funzione di “certificare” le esperienze trascorse (immagini, descrizioni, siti, cataloghi, souvenir), stimolandone momenti e modi di acquisizione;
- Fare in modo di poter coinvolgere i 5 sensi, così da poter costruire quella che si definisce esperienza “olistica”.
Questa sintesi non esaurisce certamente la complessità dell’argomento sul quale mi riprometto di tornare, tuttavia vuole offrire una “roadmap” per iniziare a pensare alla promozione turistica sotto un’altra luce (ma molti hanno già iniziato a farlo!).

da Sergio Bernardini | Set 26, 2020 | MANAGEMENT E FORMAZIONE
Una breve analisi su un metodo che consente di elaborare progetti di formazione specifici per reti di imprese per mezzo di una matrice a tre dimensioni, che può costituire una interessante opportunità per le PMI aderenti alle reti
La complessità del momento e le difficoltà economiche attuali, impongono la revisione dei modelli organizzativi specialmente nell’ambito delle PMI.
Assume notevole rilevanza anche la preparazione del personale impiegato o da reperire, per cui la formazione, spesso trascurata, è un fattore di successo da non sottovalutare.
Le PMI in tal senso scontano maggiori difficoltà rispetto alle imprese più grandi perché non hanno la forza di strutturare progetti formativi proprietari, per cui devono affidarsi a ciò che il mercato della formazione offre.
La possibilità di creare reti di imprese permette alle PMI di trovare soluzioni al problema, con l’opportunità di realizzare progetti formativi dotati di standard adeguati a soddisfare le esigenze delle imprese aderenti, con notevoli risparmi sui costi e con la possibilità di accedere con più facilità ai canali della formazione finanziata.
Adottando un metodo progettuale per “cluster” si riesce più agevolmente a trovare una risposta alla domanda di specificità di cui ha bisogno ogni impresa per la formazione delle proprie risorse umane.
Parlerò di un metodo da me utilizzato con ottimi risultati in organizzazioni complesse, molto diverse tra loro anche per cultura, che condividevano soltanto settore di attività e obiettivi comuni di missione.
Con tale metodo progettuale, le numerose attività formative, molto frammentate da paese a paese, hanno trovato un comune denominatore e uno standard da seguire.
Utilizzando una matrice a tre dimensioni, come si vede in figura, si possono collocare su ogni asse i fattori fondamentali di un qualsiasi progetto formativo.
Ogni dimensione consta di una serie di “cluster” che rappresentano gli elementi fondanti a cui un’attività formativa deve dare risposta:
- Personale partecipante: a partire dalla leadership e dal management passando per i dipendenti nei vari ruoli, fino agli aspiranti all’impiego che, auspicio di tutte le imprese, si vorrebbero già pronti. Pur nella diversità di ogni impresa, alcuni ruoli svolgono funzioni ed hanno attribuzioni simili, specialmente tra aziende dello stesso settore; pensiamo ad esempio ad un responsabile amministrativo, a un responsabile marketing o a un funzionario commerciale.
- Job requirement: le abilità, capacità e competenze necessarie ad assolvere una certa funzione. Ad esempio, l’uso di metodi di auditing e di controllo piuttosto che l’utilizzo di strumenti per il web marketing sono competenze necessarie in certe funzioni assai comuni in molte imprese, fatte salve le particolarizzazioni eventuali.
- Cluster knowledge: i “gruppi” di conoscenze e cognizioni necessarie per consentire di assolvere con efficacia a determinate funzioni; ad esempio sono dei “cluster” norme e regole di contabilità, la pianificazione strategica, il digital marketing, i social media, etc. Questi “cluster” di conoscenze sono forniti da un insieme di aspetti teorici e di applicazioni pratiche, e devono consentire al personale di applicarsi speditivamente e con efficacia alle proprie funzioni, accorciando i tempi di acquisizione del “know-how” personale, generando più rapidamente economie di scala e, fatto non secondario, relazionarsi efficacemente con gli altri attori coinvolti nel processo.
Naturalmente i cluster delle tre dimensioni variano in base alle imprese partecipanti ad una rete, richiedono un’attenta analisi e non sono standardizzabili in “copia e incolla”.
Questo lavoro di analisi e scomposizione delle abilità lavorative e delle conoscenze necessarie è propedeutico alla progettazione delle attività formative.
Una volta definiti i vari cluster di conoscenze, questi potranno essere combinati con un sistema modulare per diventare corsi che rispondano all’esigenza di indicare dei destinatari, degli obiettivi formativi, e degli argomenti da trattare.
Questo metodo di progettazione possiede diverse proprietà:
- Modularità: la definizione di cluster che formeranno i vari corsi e la determinazione iniziale delle competenze necessarie alle varie funzioni, facilitano la creazione di più corsi di minor durata da seguire con maggior facilità e con una logica di progressività da parte del personale partecipante.
- flessibilità: la struttura della formazione per moduli consente di creare varianti che possano attagliarsi meglio alle esigenze di alcune imprese, conservando al contempo l’architettura complessiva del progetto.
- Facilità di aggiornamento: la struttura modulare consente di intervenire facilmente su quei moduli che debbano essere aggiornati o modificati, ovvero che non risultino adeguati per efficacia o per i trainer, mantenendo inalterata la struttura complessiva.
- Risparmi nei costi di progettazione e svolgimento: standardizzazione e modularità consentono risparmi nella progettazione, organizzazione e svolgimento delle attività e facilitano la possibilità di accedere alla formazione finanziata con la presentazione di progetti ad ampio respiro.
- Condivisione di conoscenze: all’interno di un’impresa si rende più semplice la condivisione di quelle conoscenze comuni che possano diminuire le conflittualità interne tra le varie funzioni a tutto beneficio dell’efficienza.
Un metodo non semplice, ma fortemente consigliato ad una rete di PMI che vogliano puntare sulla formazione come fattore critico di successo, realizzando un progetto ad ampio respiro in grado di funzionare con una logica e una visione pluriennale.

da Sergio Bernardini | Ago 23, 2020 | PIANIFICAZIONE STRATEGICA E MARKETING
Torniamo a parlare di obiettivi , tema centrale della pianificazione aziendale per esaminare alcuni aspetti inclusa la decodifica dell’acronimo S.M.A.R.T. di provenienza anglosassone.
Le cinque iniziali significano:
- Specific – specifico;
- Measurable – misurabile;
- Achievable (Assignable) – realizzabile (attribuibile a chi);
- Realistic (Relevant) – realistico (pertinente);
- Time-bound – in tempi stabiliti;
Non tragga in inganno la apparente banalità di questo concetto che non è poi così scontato; basterà provare ad applicare il metodo nella formulazione di obiettivi per accorgersi che non è poi così facile come sembra.
Non a caso nel mio precedente articolo obiettivi generali nel digital marketing parlavo di categorie di obiettivi, perché se prendiamo ad esempio l’obiettivo “incrementare le vendite” (quale impresa non desidera farlo?), una formulazione così fatta non risponderebbe certo ai requisiti “SMART”.
Pertanto l’adattamento alle varie realtà delle categorie citate in quell’articolo, dovrà senz’altro essere fatta utilizzando il metodo SMART appena descritto.
Ma c’è un’altro aspetto che va sottolineato.
Alcuni obiettivi dimostrano di avere un’ampiezza e una proiezione temporale ben più vasta di altri.
Anche in questo caso devo prendere a riferimento la terminologia anglosassone, che in parte denota il diverso approccio culturale al problema.
Infatti nelle procedure di pianificazione si possono incrociare le definizioni di “goal” e “objective” che nella nostra traduzione letterale corrispondono entrambi alla parola obiettivo; in realtà non è corretto.
Nel loro approccio alla materia, la definizione di “goal” di norma sta per “dichiarazione che definisce ciò che un’organizzazione si propone di realizzare a livello economico, organizzativo o progettuale, breve e chiara definizione di risultati da raggiungere entro un periodo di tempo in linea di massima di 3-5 anni.”
Invece il termine “objective” è “una definizione specifica, misurabile, attuabile, realistica e limitata nel tempo (di norma entro un’anno) che indica le azioni da intraprendere per realizzare un obiettivo particolare funzionale al raggiungimento di obiettivi (goals) strategici”.
Esistono numerose definizioni e sfumature, per cui senza estenuanti sofismi ritengo comunque consigliabile adottare una distinzione tra “scopo” (goal) e “obiettivo” (objective), dove questi ultimi sono più specifici, limitati nel tempo e nello spazio e forniscono maggiori dettagli rispetto allo/agli scopi.
Altro aspetto che richiederebbe un’analisi accurata riguarda le relazioni tra i vari obiettivi: “incrementare le vendite” è un obiettivo realizzabile quale conseguenza (effetto) del raggiungimento di altri obiettivi o di serie di azioni a premessa, che potrebbero ad esempio consistere in “lancio di 2 nuovi prodotti sul mercato entro l’anno” oppure “realizzare due campagne promozionali di sconti sul prodotto entro l’anno” e via dicendo.
Per brevità mi riprometto di tornare su quest’ultimo punto in futuro per delineare un metodo di approccio e sviluppo.